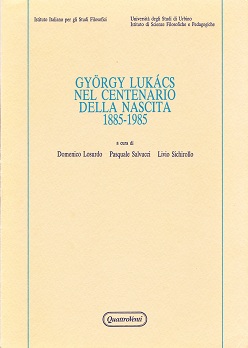di Cesare Cases
[Scheda]
«Società», 6, dicembre 1955
Nella prefazione a questo volume, l’a. esprime la speranza che gli sia possibile un giorno «trattare i problemi dell’estetica nel loro ordine sistematico». Si deve qui probabilmente scorgere un’allusione a un’opera sui problemi del rispecchiamento estetico a cui L. sta attualmente lavorando e un capitolo della quale (sul «problema della particolarità nella filosofia classica tedesca») è stato pubblicato nella «Deutsche Zeitschrift für Philosophie» (n. 4, 1954). Quest’opera esaminerà in particolare la differenza tra rispecchiamento scientifico e rispecchiamento estetico della realtà e la definizione di questo ordine di problemi ad opera di uno studioso del valore di L. sarà certo di grande importanza ai fini dell’elaborazione di un’estetica marxista. Avremo così modo di confrontare il pensiero di L. con le obiezioni mosse da Galvano della Volpe (Il verosimile filmico ed altri scritti di estetica, Roma, 1954, p. 121) di fronte ad accenni contenuti in altre opere.
In attesa di questo volume che dovrebbe dare un carattere più decisamente sistematico al pensiero estetico di L., eccoci di fronte a una raccolta di saggi sulla storia dell’estetica, scritti in varie epoche e in varie occasioni. Accanto a tre lunghi studi (sull’Estetica di Schiller, su Karl Marx e Friedrich Theodor Vischer e su Franz Mehring) troviamo qui un più breve saggio su Nietzsche come precursore dell’estetica fascista e tre introduzioni (all’Estetica di Hegel, agli scritti estetici di Cernicevski e a quelli di Marx ed Engels, quest’ultima già tradotta in italiano nel volume Il marxismo e la critica letteraria, Torino, 1953) nonché una conferenza su La letteratura e l’arte come superstruttura, tenuta all’Accademia ungherese delle Scienze come contributo alla discussione intorno allo scritto di Stalin sulla linguistica.
La connessione tra tutti questi saggi è data dal fatto che essi trattano momenti importanti della storia dell’estetica e attraverso i rimandi propri di un pensatore di così vasti orizzonti rischiarano anche periodi e figure non esplicitamente presi in esame. Non possiamo qui esporre né tanto meno discutere il contenuto di tutti i saggi. Rinunceremo a trattare quello su Schiller e quello su Mehring (interessante perché pone in luce i limiti lassalliani del grande critico della II Internazionale e il suo influsso sul gruppo dei brandleriani e sul loro teorico, August Thalheimer), accontentandoci di seguire due importanti problemi, e cioè il bello di natura e la definizione del tragico, così come essi si presentano nel periodo dell’elaborazione del pensiero marxiano, tra Hegel e Cernicevski da una parte e il teorico liberale Fr. Th. Vischer dall’altra. Ciò darà modo di vedere come anche in questi saggi storiografici L. tenga sempre presente l’esigenza sistematica.
Nel saggio su Cernicerski L. sottolinea l’energica rivalutazione del bello di natura operata dal critico russo contro gli idealisti. La vita, la realtà, è sempre infinitamente più varia e più ricca della opera d’arte. Ciò non significa che il bello di natura sia qualche cosa di esistente al di fuori dell’uomo. Richiamandosi a un passo di Marx dove si dice che «l’oro e l’argento non sono denaro per natura, ma il denaro è per natura oro e argento» (per le loro proprietà fisico-chimiche – quindi indipendenti dalla nostra coscienza – che, rileva Marx, determinano anche certe impressioni estetiche non senza importanza nella scelta di questi metalli come incarnazione del denaro), L. afferma (p. 146): «Il bello di natura è dunque inseparabile dal carattere oggettivo del fenomeno, ma ciò che è bello, sublime ecc. per l’uomo è contemporaneamente determinato dai suoi bisogni. Cioè il bello di natura è insieme più oggettivo e anche più soggettivo di quanto non sostenga l’estetica idealistica: è inseparabile dal mondo oggettivo della natura e può al contempo realizzarsi come bello di natura solo sul terreno dei bisogni umani».
Questa giusta concezione del bello di natura non può essere raggiunta finché si contrappone meccanicamente la natura come alcunché di assolutamente indipendente dall’uomo all’arte come attività puramente soggettiva: in questo caso avremo sempre la tendenza a oscillare tra l’esaltazione unilaterale del bello di natura (Diderot) e l’idea che il bello è un prodotto esclusivo della coscienza (Kant). Solo in Hegel (p. 117) si intuisce che «quella natura che figura come oggetto dell’estetica, in cui può apparire il bello di natura, è un terreno di interazione tra società e natura». Ma Hegel stesso finisce sovente per ricadere nel disprezzo idealistico della natura.
Ora Cernicevski, nella sua rivendicazione antiidealistica del bello di natura, cade nell’opposto eccesso di una certa svalutazione dell’arte. Egli afferma, p. es., che la riproduzione artistica del reale è utile e indispensabile, ma aggiunge «nel caso che manchi il pieno godimento estetico quale lo offre la realtà». L. commenta (p. 157): «Cernicevski contrappone all’estremo falso e unilaterale dell’estetica idealistica per cui l’arte costituisce un’“integrazione” metafisica del reale al bello di natura, dannato a un’ “eterna imperfezione”, l’altro estremo – come abbiamo visto, per molti riguardi meglio adeguato ai fatti, ma tuttavia falso – per cui l’arte rappresenta per noi solo un surrogato in casi in cui il bello di natura è per noi inattingibile per ragioni soggettive o oggettive». Questi limiti di Cernicevski, così come la sua scarsa sensibilità per i problemi della forma, sono una conseguenza dell’antropologismo feuerbachiano, che esalta la «vita» come un dato senza esaminarne da vicino le articolazioni.
Per quel che riguarda la definizione del tragico (argomento già affrontato p. es. nel saggio sulla polemica tra Marx-Engels e Lassalle a proposito del Sickingen di questo ultimo, tradotto in Il marxismo ecc., cit.), interessano anzitutto le oscillazioni che essa subisce nella estetica di Fr. Th. Vischer in corrispondenza alla sua involuzione politica. La necessità tragica era notoriamente per Hegel l’espressione della necessità del decorso storico, per cui nel cozzo tra due stadi dell’evoluzione dello Spirito quello storicamente superato deve fatalmente soccombere. L’esempio più noto è il conflitto tra famiglia e Stato nell’Antigone, ma già esso porta tratti moderni e l’analoga analisi di Shakespeare come interprete del tramonto dell’epoca «eroica» medioevale di fronte alla moderna «società civile» mostra come per Hegel il conflitto tragico per eccellenza sia quello in cui il passato preborghese cede le armi di fronte alla società borghese sviluppata. La sola tragedia nota a Hegel è dunque quella del conservatore venuto troppo tardi, mentre Marx ed Engels aggiungono quella di Thomas Münzer, cioè del rivoluzionario venuto troppo presto (un esempio isolato di questo tipo è, nelle lezioni hegeliane sulla Storia della filosofia, Socrate, anticipatore del Cristianesimo).
Già nella sua Estetica Vischer, pur prendendo le mosse da Hegel, modifica la concezione del tragico nel senso che «l’eroe stesso deve essere convinto della necessità della sua fine». Ne consegue da una parte una soggettivizzazione del conflitto (che in Hegel aveva basi oggettive: la fine di Antigone è la fine di un mondo) e dall’altra una sua generalizzazione in senso formalistico, per cui tutto è necessario. Ciò emerge chiaramente nell’atteggiamento di Vischer di fronte alla rivoluzione del ’48. La necessità tragica è sia nella controrivoluzione che nella debolezza della borghesia rivoluzionaria «convinta» di dover fallire. L. così riassume tale posizione (p. 242): «È dunque in egual modo “tragicamente necessario” che gli Hohenzollern dominino incontrastati sulla Germania come è “tragicamente necessario” che i borghesi tedeschi e i loro ideologi lecchino gli stivali degli Hohenzollern». Più tardi il riconoscimento della necessità del fatto compiuto porta Vischer ad accettare la soluzione bismarckiana e a giustificare la guerra del ’66 col fatto che «ci sono situazioni tragiche in cui se non si agisce una vecchia colpa continuerà a portare sempre nuovi mali, eppure, non si può agire senza commettere nuove colpe». La concezione irrazionalistica soggiacente a questa teoria della necessità tragica è espressa chiaramente in una lettera della stessa epoca: «Non ho perduto la fede in una legge che governa la storia. Ma noi non possiamo conoscere le vie di questa legge… La prospettiva è falsa: non è per una via organica, ma per una via caotica che le cose possono cambiare». È chiaro il collegamento tra queste concezioni e quelle dello Hebbel postquarantottesco (il «sonno del mondo» di Gige e il suo anello) trattate altrove da L. Qui egli insiste sulla linea che conduce da questo irrazionalismo di Vischer, attraverso la teoria dell’Einfühlung che egli mutua negli ultimi scritti dal figlio Robert, a Dilthey e al moderno irrazionalismo estetico (cui è dedicato anche il saggio su Nietzsche).
Il disfattismo della concezione vischeriana del tragico è aspramente combattuto da Cernicevski. I suoi colpi sono diretti anzitutto contro l’idea di «destino» che serve a fondare tale disfattismo e che è ripresa da tutta la drammaturgia dell’Ottocento dalla Schicksalstragödie in poi. La nuova importanza assunta da quest’idea dopo che essa era stata respinta dall’Illuminismo (si ricordi il motto napoleonico «il destino è la politica», convalidato da Goethe) si deve, ricorda L., all’incertezza delle basi dell’esistenza individuale nel regime capitalista. La critica di Cernicevski rivela brillantemente come le teorie dell’estetica liberale sulla «necessità» e la «colpa tragica» costituiscano una giustificazione degli orrori della società classista. Perciò egli dà la seguente definizione del tragico: «Il tragico è il terribile nella vita umana». Tale identificazione del tragico col terribile equivale, dice L. (p. 179) «a un appello alla lotta rivoluzionaria contro tutti gli orrori dovunque essi si rivelino, sia nella indifferenza della natura di fronte agli uomini, sia nella convivenza sociale degli uomini stessi».
Ma al solito anche qui si manifestano i limiti dovuti all’antropologismo di Cernicevski. Nella sua lotta contro la «necessità tragica» egli sottolinea il carattere accidentale del tragico concepito come terribile. Almeno nella vita, egli afferma, un destino tragico può essere del tutto accidentale senza cessare di essere tragico (e dà come esempio la morte di Gustavo Adolfo a Lützen, al colmo dei suoi trionfi). Ora in tal modo per negare la «necessità tragica» generalizzata dai teorici liberali si viene a negare ogni e qualsiasi necessità tragica come fatto sociale inevitabile. Tale è difatti la concezione esposta nel romanzo Che fare?, dove tutti i conflitti insolubili dal punto di vista borghese vengono appianati grazie all’elevatezza morale e intellettuale dei protagonisti. L. riconnette a questa concezione (di carattere sostanzialmente illuministico) la teoria dell’«assenza di conflitti» per qualche tempo sostenuta nell’Unione Sovietica. (Interessanti sviluppi delle idee di L. sul tragico si possono ora vedere nello studio di Hans-Günther Thalheim, Schillers “Demetrius„ als Klassische Tragödie in “Weimarer Beiträge„ I-II-1955).
Non possiamo abbandonare il libro di L. senza esserci soffermati sull’importante conferenza La letteratura e l’arte come superstruttura. Qui si insiste dapprima sul carattere superstrutturale di entrambi i campi, da molti contestato sulla scorta di un’erronea interpretazione degli articoli di Stalin sulla linguistica («forse ognuno è disposto ad accettare come superstruttura la specialità dell’altro», annota ironicamente L.). In secondo luogo si dimostra come la superstruttura letteraria e artistica sia collegata alla produzione solo indirettamente, attraverso la base. Qui L. riprende motivi già visti a proposito di Cernicevski. Mentre nella scienza gli strumenti di osservazione si emancipano sempre più dagli organi sensoriali, l’arte non ne può mai superare i limiti; può però, entro questi limiti, variare, perfezionare e raffinare i propri strumenti. «Tutto ciò riposa proprio sul fatto che l’arte rispecchia immediatamente soltanto i rapporti di produzione, mentre rispecchia solo attraverso la loro mediazione tutto il resto, cioè precisamente la natura. Si ha così la peculiare oggettività della rappresentazione artistica, la necessaria presenza dell’uomo nel rispecchiamento della realtà oggettiva, senza che ne sia annullata la oggettività» (p. 417). L. dà l’esempio dell’evoluzione della natura morta dagli olandesi a Cézanne e Van Gogh: proprio qui, dove il tema immediato è soltanto la natura, si può cogliere lo stretto nesso tra il suo rispecchiamento e i rapporti sociali, l’ordine della produzione.
Infine L. sviluppa il discorso, già accennato nella Skizze einer Geschichte der deutschen Literatur, sulle ragioni della sopravvivenza delle opere d’arte. Egli parte dalla constatazione che ogni classe riprende quella parte della superstruttura del passato che può utilizzare nella sua lotta, ciò che dà luogo a sopravvalutazioni e deformazioni. L’avvento del socialismo pone termine a questo modo di risuscitare l’arte del passato, ma ciò non significa che essa cessi di interessarci ove non ci siano più classi che hanno interesse a richiamarsi ad essa. Anzi proprio l’estinzione della lotta di classe pone i presupposti per un’esatta valutazione dell’eredità artistica. Rifacendosi alla nota frase di Marx nell’Introduzione alla critica della economia politica, L. così definisce, in maniera, ci sembra, anch’essa «classica», le ragioni della sopravvivenza delle opere d’arte: «L’arte greca agisce quindi su di noi come la “infanzia normale”, che non ritornerà mai, dell’umanità; dunque nel ricordo, come fissazione artistica di un’importante tappa del cammino finora percorso dall’umanità. E anche qui non si tratta di un qualsiasi ricordo di questa tappa, bensì esclusivamente di un ricordo che concentra in forma classica i fattori decisivi della tappa stessa (usando l’aggettivo “classico” nello stesso senso in cui lo definisce Engels nelle sue ricerche sui rapporti tra logica e storia). Di conseguenza nell’effetto estetico che fa dei poemi di Omero “una norma e un modello ineguagliabile” è inscindibilmente implicito anche il carattere superstrutturale dell’arte: le grandi opere d’arte rispecchiano in modo esemplare la base, i rapporti di produzione e i rapporti sociali fondamentali della loro epoca» (pp. 424-25). Questo per quanto riguarda il contenuto. Ma anche la forma «è tanto più compiuta, quanto più organicamente essa collega i rapporti più essenziali di una base concreta (cioè dei rapporti umani che la costituiscono) con la capacità di rendere plasticamente sensibili uomini concreti, quindi individualizzati. Quanto più una forma artistica ci può mettere in grado di rivivere immediatamente i rapporti umani concreti da essa rappresentati e tanto pili sicura è la sopravvivenza dell’opera d’arte in questione. Tanto più infatti anche l’uomo di un lontano futuro sarà in grado di riconoscere immediatamente se stesso negli uomini e nelle vicende rappresentate e nel mondo oggettivo che media queste vicende, di riconoscere il proprio passato nel passato dell’umanità» (p. 425).
Cesare Cases